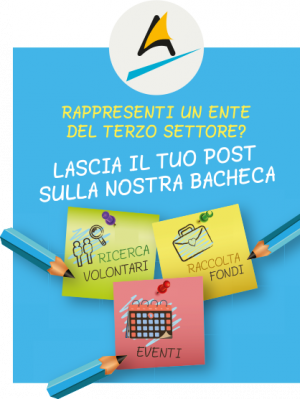PALERMO. Il laboratorio “Chiamati a deporre. La poesia come testimonianza” si è tenuto nelle date 9 e 10 marzo presso il Complesso Universitario S. Antonino, Aula Tindara Ignazzitto. L’evento, inserito all’interno delle attività dell’insegnamento Lingua e testualità del Corso di Laurea in Lettere, è stato voluto e organizzato dai docenti dell’Università di Palermo Marina Castiglione e Vincenzo Pinello, con la collaborazione del Laboratorio Somiglianze.
Il laboratorio è stato guidato dalla poetessa Alessandra Carnaroli, voce poetica tra le più limpide e potenti del panorama letterario contemporaneo e autrice della recente spiazzante silloge “50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti”.
Alessandra Carnaroli ha lavorato sui testi e creato poesia con 21 studenti del Dipartimento di scienze umanistiche, e non solo. “La realtà molto composita ed eterogenea del gruppo”, come afferma Pinello, “ha permesso un arricchimento del confronto all’interno del laboratorio£”.
Riguardo al titolo del laboratorio “Chiamati a deporre. La poesia come testimonianza”: si tratta di una metafora giuridica?
Il professore Pinello, rispondendo alla domanda, fornisce una personale prospettiva sul titolo. Per comprendere appieno le sue parole rileggiamo la scheda di presentazione del laboratorio, in cui Carnaroli scrive:
La poesia come deposizione, come voce che dà la sua versione del mondo, si posa sulle cose.
Poesia che abbandona, appoggia borse e persone, espelle uova.
Poesia per deporre corpi
armi, corone e detriti sul fondo.
La propria testimonianza.
Essere testimoni di sé e dell’Altro
Secondo Pinello, da un lato c’è la poesia che funge da testimonianza in prospettiva storica, mentre dall’altro vi è la testimonianza del presente, come atto di coraggio del racconto dei tempi di oggi. Tuttavia, c’è anche un secondo significato, commenta Pinello, che possiamo ritrovare nella espressione “espelle uova”: uova inteso come l’archetipo di origine della vita.
Il professore continua affermando che in Carnaroli funziona molto questo dialogo tra archetipo e un bisogno ossessivo di semplicità espressiva, tanto da utilizzare non solo la lingua e le parole del quotidiano, ma anche gli oggetti del quotidiano. C’è questa capacità di poter riscoprire il significato profondo nella quotidianità immediata. Il tutto, continua Pinello, in maniera non contraddittoria ma in un unico sistema organico.

Cosa ha mosso l’intenzione di costruire questo laboratorio e come mai proprio la scelta di Alessandra Carnaroli come protagonista?
Pinello racconta di seguire il lavoro letterario della Carnaroli da diversi anni e nello spiegare la scelta della Carnaroli come protagonista si riferisce alla creatività linguistica affermando che “è una componente fondamentale della lingua e riguarda la capacità di creare attraverso gli elementi linguistici a disposizione nuovi sistemi linguistici o nuove modalità espressive, in questo lei” – la Carnaroli – “è una delle autrici più rappresentative perché è capace, attraverso il lavoro laboratoriale di creazione, distruzione e ricostruzione delle parole, di dare forma e sostanza a un moto che è continuamente ondulatorio tra le origini, gli archetipi e il quotidiano”. Ero sicuro – continua Pinello – che “tutto questo, innestato in un laboratorio con studenti, a mio avviso avrebbe avuto […] un impatto molto positivo”.

Perché è importante parlare di poesia per noi futuri insegnanti, e soprattutto che ruolo ha una poesia non edulcorata, ma viva e pungente come quella della Carnaroli?
Per rispondere alla domanda Pinello si riferisce ad una lezione del corso di didattica dell’italiano per insegnanti in formazione: “giusto ieri abbiamo iniziato a ragionare sul tema del testo letterario; innanzitutto dobbiamo dire che in maniera molto esplicita nelle indicazioni nazionali del 2012 si parla di un certo tipo testi letterari già in riferimento alla scuola dell’infanzia, ad esempio filastrocche e narrazioni. Per la scuola scuola primaria si prevede già un vero e proprio incontro con il testo letterario e con la poesia andando contro ad un pregiudizio antico, che io ormai penso superato, secondo il quale il testo letterario essendo difficile deve essere rimandato sempre nei livelli scolastici successivi.”
Pinello continua affermando che posticipare l’approccio alla poesia “crea un vulnus molto grave nella formazione dell’apprendente, come se il testo letterario fosse qualcosa di intoccabile, inarrivabile.”
Secondo Pinello “sul testo letterario in particolare e sulla testualità in generale la formazione dell’insegnante deve essere molto completa, e dunque molto solida: sia in ambito linguistico e sociolinguistico; sia circa la conoscenza delle funzioni e degli stilemi fondamentali della cultura in Italia in Europa; sia circa tutte le pratiche di scrittura e riscrittura linguistica” perché “tanto più ampia è la formazione del docente tanto più avrà successo l’intervento didattico”.
Pinello afferma che è necessario rompere un pregiudizio circa la didattica del testo poetico secondo cui “dato che io insegnante devo lavorare soltanto con le poesie di Gianni Rodari e le filastrocche, debbo conoscere solo Gianni Rodari e le filastrocche…”; tale prospettiva, continua il Professore “non porterà mai ad una didattica adeguata, coinvolgente e profonda, che giunga al cuore della lingua”
Pinello continua riferendosi all’importanza e al valore della creatività linguistica, ampiamente promossa dalla letteratura italiana e francese, secondo cui un testo contiene “celati” tanti altri testi. Per fare un esempio, “tra le pratiche di manipolazione testuale ricordiamo la poesia inversa o antonimica, in cui a partire da un testo poetico il compito è quello di smontarlo attraverso la sostituzione delle parole piene con i loro contrari”.
Il Professore continua affermando che queste pratiche hanno numerose funzioni didattiche: “il potenziamento lessicale, perché, soprattutto se proposte con l’ausilio del dizionario, viene offerto un arricchimento lessicale molto importante; inoltre il piccolo alunno si trova a entrare già dentro la sintassi del testo, benché ancora non ne abbia consapevolezza; avviene quella che io chiamo detabuizzazione testuale, cioè i testi letterari, anche le poesie più famose della letteratura italiana, non sono inarrivabili e intoccabili, ma sono miei amici tant’è che io ci gioco, li smonto e li rimonto.
Chiara Alongi e Maria Rita Ingallina
Studentesse Scienza della Formazione Primaria
Università degli Studi di Palermo